Cos’è E621?
E621 è il nome internazionale dell’additivo alimentare conosciuto come glutammato monosodico (MSG) o glutammato di sodio. Questa sostanza, codificata come 29224220 nel sistema armonizzato, è ampiamente utilizzata dall’industria alimentare come esaltatore di sapidità.

Negli ultimi decenni, si è diffusa una sorta di avversione collettiva verso l’utilizzo di E621. Questo pregiudizio è emerso nella seconda metà del XX secolo, in particolare con la “scoperta” della presunta “Sindrome da Ristorante Cinese”, ma si è intensificato soprattutto negli anni 2000. Questa diffidenza ha spinto le industrie alimentari a eliminare l’uso di E621 o a creare linee di prodotti senza tale additivo. Tuttavia, bisogna sottolineare che l’E621 è un composto innocuo. Non esistono prove scientifiche che dimostrino un impatto negativo sulla salute umana, a parte alcune eccezioni che potrebbero essere correlate a condizioni patologiche preesistenti.
L’acido glutammico è un amminoacido non essenziale presente in natura in molti alimenti comuni, come alghe, pomodori, uva, formaggio e funghi. Il sodio, invece, è un elettrolita naturalmente presente negli alimenti e particolarmente abbondante nel sale da cucina. È importante sottolineare che un’eccessiva assunzione di sodio nella dieta, soprattutto se associata al consumo di cibi ipercalorici, grassi e salumi, può favorire lo sviluppo o l’aggravarsi dell’ipertensione arteriosa sensibile al sodio.
Il glutammato monosodico, o E621, viene utilizzato in cucina principalmente per migliorare il sapore e l’umami di cibi con caratteristiche organolettiche e gustative delicate, soprattutto carni, e per armonizzare e accentuare la percezione di altri sapori.
Ciò che molti non sanno è che la formazione del glutammato monosodico è un processo chimico-fisico spontaneo che avviene durante la cottura prolungata di ricette contenenti livelli significativi di acido glutammico e sodio, come brodi, zuppe, stufati e brasati, ma anche durante la stagionatura.
In realtà, l’uso di brodi e fondi di cottura per migliorare il sapore delle ricette è una pratica culinaria che si tramanda da secoli. L’industria alimentare ha semplicemente “copiato” questo processo e lo ha reso disponibile in modo pratico, permettendo di aumentare la quantità di acido glutammico anche nelle preparazioni a cottura veloce.
Il biochimico giapponese Kikunae Ikeda fu il primo a isolare il glutammato monosodico nel 1908. Egli cercò di replicare il caratteristico sapore sapido dell’alga kombu, utilizzata come base per molte zuppe giapponesi.
Il controverso additivo alimentare
La storia dell’E621, noto come glutammato monosodico, ha radici che risalgono al XIX secolo. Fu scoperto nel 1866 dal chimico tedesco Karl Henrich Ritthausen, durante i suoi studi sul glutine di frumento. Tuttavia, fu Kikunae Ikeda, biochimico dell’Università Imperiale di Tokyo, a isolare efficacemente il composto nel 1906, utilizzando l’alga kombu giapponese.
Ikeda notò che il brodo di kombu aveva un sapore unico, diverso dai gusti comunemente noti come dolce, salato, acido e amaro. Dopo vari esperimenti, identificò il composto responsabile di questo gusto e lo chiamò “umami”. Ikeda brevettò il prodotto come “glutammato monosodico” e avviò la produzione commerciale con l’azienda “Aji-no-moto” nel 1909.
L’E621 ha suscitato controversie, soprattutto in Occidente, non tanto per l’opposizione delle autorità, ma per le preoccupazioni espresse dai consumatori. Alcuni sociologi sostengono che il rifiuto dell’E621 da parte degli occidentali sia correlato al razzismo anti-asiatico, poiché il glutammato monosodico viene spesso associato a una sostanza “orientale” e considerato potenzialmente nocivo per la gastronomia occidentale.
Tuttavia, alcuni esperti, come il critico alimentare Jeffrey Steingarten, suggeriscono che il glutammato monosodico dovrebbe essere valutato senza pregiudizi culturali, considerando il suo uso comune in Estremo Oriente. Steingarten si chiede: “Se il glutammato monosodico è davvero un problema… perché in Cina non tutti soffrono di mal di testa?”. I glutammati sono esaltatori di sapidità e l’E621 è il più utilizzato di questa famiglia di additivi. Tuttavia, la sua sicurezza e i suoi effetti sulla salute sono ancora oggetto di dibattito.
Gli additivi alimentari a base di glutammato, come l’E621, sono associati alla cosiddetta “sindrome del ristorante cinese”, caratterizzata da mal di testa, nausea, senso di oppressione al torace e arrossamento del viso. Ci sono anche preoccupazioni riguardo alla neurotossicità dei glutammati e il loro possibile legame con malattie neurodegenerative. Inoltre, sono stati segnalati possibili effetti reprotossici ed embriotossici.
Nonostante le controversie, l’industria alimentare continua a utilizzare l’E621 come esaltatore di sapidità per migliorare o correggere il gusto di vari alimenti, come stufati, zuppe, dadi da brodo, salse, salumi e prodotti in scatola. È importante notare che il parmigiano reggiano, ad esempio, contiene naturalmente una quantità significativa di glutammato monosodico.
Sostanza letale o bufala assoluta?
L’E621, conosciuto come glutammato monosodico, è diventato famoso e demonizzato a seguito del fenomeno della “sindrome da ristorante cinese” negli anni ’60. Si trattava di una serie di sintomi apparentemente correlati al consumo di cibi ricchi di glutammato, spesso utilizzato come additivo nella cucina orientale.
Tuttavia, numerosi studi scientifici sono stati condotti successivamente (tra cui uno citato qui) e il fenomeno è stato smentito: secondo una revisione del 2006, non ci sono evidenze che il glutammato sia responsabile di tali effetti.
Esiste una dose massima di assunzione?
Secondo il Consenso del 2006 della Commissione Europea, si stima che il consumo medio europeo di glutammato vari dai 5 ai 12 g al giorno, considerando sia il glutammato libero, quello legato alle proteine e quello derivante dagli additivi. Si ritiene che si possa assumere con tranquillità fino a un massimo di 16 g/kg di peso corporeo al giorno.
Nel 2017, l’EFSA (European Food Safety Authority) ha rivalutato la sicurezza dei glutammati aggiunti come additivi alimentari e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 30 mg/kg di peso corporeo. Tuttavia, considerando anche le fonti alimentari, si supera ampiamente la DGA di glutammati senza riscontrare sintomi.
Quindi, un uomo di 75 kg potrebbe consumarne circa 2,3 g al giorno senza subire conseguenze. Cosa succede se questo uomo è un crossfitter affamato che segue una dieta per massa?
Di seguito sono riportati gli alimenti che contengono una quantità consistente di glutammato (trovate l’elenco completo qui). Il contenuto medio di acido glutammico negli alimenti è espresso in mg/100g.
- Pinoli: 6740
- Provolone: 6248
- Parmigiano: 6030
- Arachidi tostate: 5967
- Faraona (coscio): 5585
- Mandorle dolci secche: 5377
- Pecorino romano: 5115
- Salame Felino: 4944
- Faraona (petto): 4911
- Maiale (leggero, bistecca): 4611
- Bresaola: 4573
- Pollo (petto): 4572
- Tacchino (fesa): 4567
Non a caso, ho evidenziato alcuni alimenti dell’elenco… li riconoscete? Sono quelli alla base della dieta del crossfitter medio! Facendo rapidamente alcuni calcoli: consumando due porzioni abbondanti di petto di pollo (circa 400g), due pugni di mandorle (circa 50g), cinque monoporzioni di parmigiano (100g), due generose cucchiaiate di burro di arachidi (50g) e un panino con la bresaola (60g), raggiungeremmo circa i 32 g di acido glutammico, senza considerare gli alimenti non citati e gli eventuali additivi. Il risultato è ben al di là della dose massima di sicurezza.

È meglio evitarlo comunque?
Il fatto che il glutammato monosodico non sembri dannoso non significa che sia benefico. È inutile insistere nell’evitare i cibi più ricchi di acido glutammico. È meglio ridurre la frequenza di consumo degli alimenti industriali, indipendentemente dal contenuto di glutammato.
Tornando al brodino della nonna… perché non preparare un buon brodo di carne o di ossa da animali alimentati ad erba? Non ci sono prove solide che il glutammato causi danni alla salute. Non è chiaro il limite massimo giornaliero di assunzione di questa sostanza. È consigliabile ridurre il consumo di alimenti industriali in generale, compresi quelli che contengono glutammato.
Dietro l’etichetta
Da anni si discute animatamente sulla nocività del glutammato monosodico, un additivo alimentare utilizzato per conferire sapore agli alimenti industriali. Le controversie sono molteplici e le opinioni divergenti, ma cosa c’è di vero dietro questo insidioso ingrediente? Scopriamolo analizzando le informazioni tratte da una fonte autorevole.
Il glutammato monosodico, noto anche come MSG o E621, è solo una delle tante sostanze utilizzate per ottenere lo stesso effetto di sapore. Le etichette degli alimenti possono riportare appellativi diversi che nascondono queste sostanze simili: glutammato monopotassico, acido glutammico, proteine idrogenate, caseinati di calcio e di sodio, glicina. Le sigle E620-E640 identificano i vari tipi di glutammato e inositati impiegati come insaporitori.
Il glutammato monosodico è stato estratto per la prima volta nel 1908 dall’alga marina kombu, e da allora ha conosciuto una rapida industrializzazione. Inizialmente ottenuto da colture di lievito fermentate, oggi viene sintetizzato chimicamente. Il termine “umami” è stato coniato per descrivere il sapore del glutammato, che rappresenta il quinto gusto fondamentale, al pari di dolce, salato, acido e amaro.
L’argomento più dibattuto riguardo al glutammato è la sua presunta nocività. Importanti organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), non considerano il glutammato particolarmente dannoso nelle dosi impiegate nei cibi industriali. Tuttavia, negli anni ’50 sono emerse critiche e studi che evidenziavano reazioni negative conseguenti al suo consumo.
Una delle criticità riguarda la forma sintetica del glutammato, che secondo alcune ipotesi non verrebbe metabolizzata come quella naturale presente negli alimenti. Questo potrebbe spiegare alcuni effetti collaterali, ma non ci sono conferme ufficiali su questa valutazione.
È stato anche indagato il possibile impatto del glutammato sul cervello. Studi hanno esaminato la neurotossicità del composto e il suo passaggio dal sangue al cervello, ma finora non sono emerse evidenze significative di rischi. Alcuni legami ipotizzati tra consumo di glutammato e patologie neurodegenerative sono stati esclusi, anche se ulteriori approfondimenti sono ancora necessari. Tuttavia, per precauzione, si consiglia alle persone affette da tali malattie di evitare alimenti con elevate concentrazioni di glutammato.
Altri possibili risvolti negativi del consumo di glutammato includono disturbi di comportamento e apprendimento, nonché la depressione. Tuttavia, va sottolineato che tali correlazioni non sono ancora state dimostrate scientificamente.
Per quanto riguarda le donne in gravidanza, studi hanno dimostrato che anche con elevate concentrazioni di glutammato nel sangue materno, la sostanza non riesce ad attraversare la placenta, escludendo così un possibile impatto negativo sul feto.
Altre domande frequenti
Sempre su questo argomento
- Film E Programmi Tv Di Bill Cosby
- Stambecco
- Passignano sul Trasimeno
- Spray al peperoncino
- Come recuperare password su Tiscali Mail
- Bulldog francese blu
- Palette autunno
- Polinesia
- Allianz Bank
- MKM
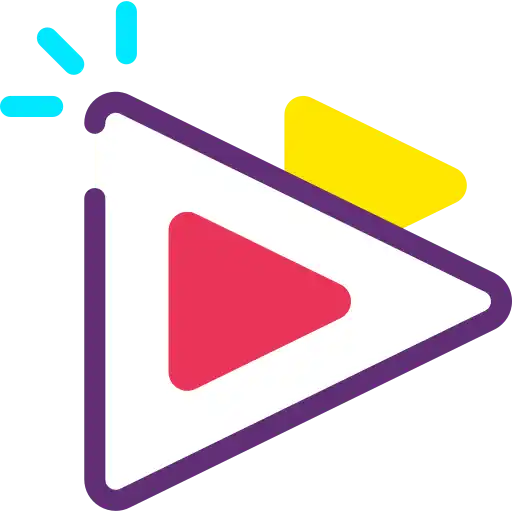 Programmazione Tv
Programmazione Tv









