L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è un’organizzazione italiana che si occupa dello studio dei fenomeni geofisici, sismici e vulcanologici. Fondata nel 1999, l’INGV ha il compito di coordinare le attività di ricerca nel campo della geofisica e della vulcanologia in Italia.
L’INGV ha una serie di responsabilità cruciali nel monitoraggio e nella ricerca dei fenomeni naturali legati alla terra. Tra le sue principali responsabilità vi è il monitoraggio sismico. Attraverso una rete di sismografi e stazioni di monitoraggio sismico distribuite sul territorio nazionale, l’INGV raccoglie dati sismici in tempo reale per monitorare l’attività sismica e fornire avvisi tempestivi in caso di eventi significativi.

Vulcanologia
Un’altra importante responsabilità dell’INGV è la vulcanologia. L’istituto monitora costantemente l’attività dei vulcani italiani, come l’Etna, il Vesuvio e lo Stromboli. Utilizzando strumenti di monitoraggio come sismografi, inclinometri e telecamere termiche, l’INGV fornisce informazioni sullo stato di attività dei vulcani e contribuisce alla prevenzione e alla gestione del rischio vulcanico.
Oltre al monitoraggio sismico e vulcanologico, l’INGV si occupa anche dello studio degli effetti dei terremoti sull’ambiente e sulle strutture. Attraverso analisi dettagliate dei dati sismici e modelli di propagazione delle onde sismiche, l’istituto contribuisce alla valutazione della pericolosità sismica e allo sviluppo di normative di sicurezza antisismica.
La ricerca scientifica è un altro aspetto fondamentale dell’attività dell’INGV. L’istituto svolge una vasta gamma di ricerche nel campo della geofisica e della vulcanologia, al fine di comprendere i processi fisici che si verificano all’interno della Terra, migliorare la conoscenza dei fenomeni naturali e sviluppare modelli predittivi per prevedere l’evoluzione dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche.
Collaborazioni scientifiche
L’INGV collabora attivamente con altre istituzioni scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale, per promuovere lo scambio di conoscenze e la cooperazione nel campo della geofisica e della vulcanologia. Inoltre, fornisce informazioni e servizi di divulgazione al pubblico, contribuendo alla sensibilizzazione e all’educazione sulla prevenzione dei rischi sismici e vulcanici.
Complessivamente, l’INGV svolge un ruolo di primaria importanza nel monitoraggio e nella ricerca dei fenomeni geofisici e vulcanologici in Italia, contribuendo alla sicurezza e alla protezione della popolazione e dell’ambiente.

Storia dell’INGV
Nel settembre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha celebrato il suo ventesimo anniversario dalla sua costituzione. L’INGV è il risultato della fusione dei principali istituti di ricerca geofisica e vulcanologica italiani, tra cui l’Istituto Nazionale di Geofisica di Roma, l’Osservatorio Vesuviano di Napoli, l’Istituto Internazionale di Vulcanologia del CNR di Catania, l’Istituto di Geochimica dei Fluidi del CNR di Palermo e l’Istituto di Ricerca per il Rischio Sismico di Milano. Ripercorriamo insieme i momenti salienti della lunga storia dell’INGV, che ebbe inizio nel 1936 con una disposizione presidenziale firmata da Guglielmo Marconi, all’epoca presidente del CNR.
La nascita dell’INGV si colloca negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. Il capo del governo dell’epoca, Mussolini, considerava la ricerca di importanza strategica per garantire l’autonomia nello sviluppo e nella gestione delle risorse nazionali, specialmente durante gli anni dell’autarchia. Di conseguenza, nel 1923, fu creato il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con l’obiettivo principale di promuovere la ricerca scientifica, colmando le lacune dei laboratori universitari spesso oberati di lavoro didattico. Il matematico Vito Volterra fu il primo presidente del CNR, seguito in seguito da Guglielmo Marconi.
Dopo un periodo di consolidamento, nel 1936 il CNR decise di valutare lo stato degli studi e dei servizi geofisici nel Regno d’Italia per intervenire, se necessario, con nuove istituzioni nel campo delle discipline geofisiche. Fino ad allora, gli studi geofisici erano sviluppati separatamente in vari ambiti di ricerca, come i fenomeni atmosferici, marini e quelli della Terra solida, nel contesto della geografia o delle scienze naturali, l’ottica atmosferica nell’ambito astronomico e il magnetismo terrestre nella fisica generale. Per quanto riguarda i servizi geofisici, affidati al Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica, erano stati praticamente trascurati, poiché l’ufficio si era concentrato principalmente sulla climatologia e la meteorologia agraria.
In quel periodo, c’erano ricercatori con solide competenze geofisiche sia nell’ambito universitario, come professori o liberi docenti, sia negli osservatori pubblici e privati sparsi nel territorio italiano. Tra questi, una figura di spicco era Antonino Lo Surdo, un rinomato scienziato di fama internazionale. Nel 1939, Lo Surdo ottenne l’incarico di professore di Fisica Superiore presso l’Università di Roma e divenne anche il direttore dell’Istituto di Fisica.
Dopo la morte di Antonino Lo Surdo nel giugno 1949, l’ING (Istituto Nazionale di Geofisica) continuò a consolidarsi come un punto di riferimento per la geofisica in Italia. Nonostante le difficoltà causate dalla Seconda Guerra Mondiale, l’ente era riuscito a costituirsi come un’istituzione autonoma nel campo delle scienze geofisiche.
Nel periodo successivo alla guerra, le attività dell’ING ripresero gradualmente. Nel 1948, la rete geofisica comprendeva dodici stazioni e osservatori situati in diverse città italiane, come Roma, Trieste, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Catania e Messina. Erano in programma la costituzione di altre sette stazioni per le quali erano già disponibili gli strumenti, e si stavano anche facendo le pratiche per creare una stazione sismica a Merano. Inoltre, l’ING assunse anche la responsabilità delle attività di magnetismo terrestre, in particolare nell’istituzione della Rete Magnetica Italiana, che comprendeva un osservatorio centrale e stazioni periferiche.
Durante questo periodo, Antonino Lo Surdo aveva proposto la pubblicazione di un “Trattato di Geofisica“, un’opera che rappresentasse una completa sintesi delle conoscenze geofisiche dell’aria, dell’acqua e della litosfera. L’amministrazione dell’ING sperava di completarlo in tempo per il X Congresso dell’UGGI (Union Géodésique et Géophysique Internationale) che si sarebbe tenuto a Roma nel 1954 presso il CNR. Tuttavia, a causa della mancanza di fondi, il volume non fu mai pubblicato.
Un’importante iniziativa di Lo Surdo che ebbe maggior successo fu la creazione della rivista “Annali di Geofisica” nel 1948. La rivista aveva lo scopo di accogliere contributi scientifici nel campo della geofisica e colmava una lacuna nella pubblicazione scientifica italiana. A partire dal 1950, le pagine degli “Annali di Geofisica” ospitarono i contributi di illustri sismologi stranieri come J.P. Rothé, K.E. Bullen, L. Mintrop, B. Gutenberg, V. Keylis-Borok e R. Teisseyre.
Nonostante le sfide incontrate durante la sua fase di fondazione, l’ING si affermò come un’importante istituzione geofisica in Italia, aprendo la strada a ulteriori sviluppi e progressi nel campo della ricerca geofisica nel paese.
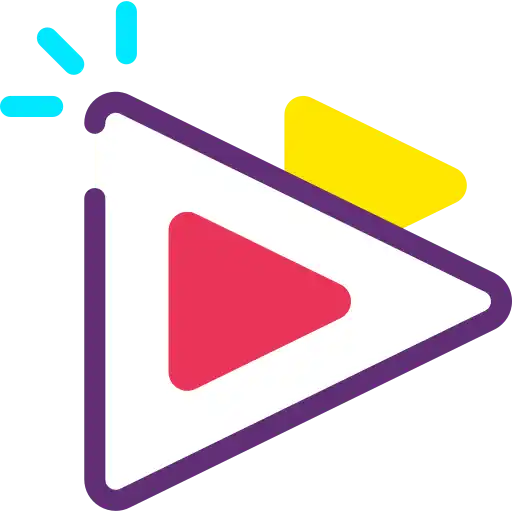 Programmazione Tv
Programmazione Tv









