Scrivere un testo argomentativo richiede una struttura e una metodologia specifiche. Ecco una guida su come scrivere un testo argomentativo in modo efficace.

Quando ci si appresta a scrivere un testo argomentativo, è fondamentale seguire una serie di passaggi ben definiti. Il primo step consiste nella scelta dell’argomento da affrontare. È importante selezionare un tema di interesse personale su cui si desidera esprimere un punto di vista chiaro e convincente. L’argomento scelto deve essere attuale, rilevante e suscitare dibattito.
Successivamente, è necessario condurre una ricerca approfondita sull’argomento scelto. Bisogna raccogliere tutte le informazioni necessarie da fonti affidabili come libri, articoli, studi accademici o fonti online autorevoli. È importante prendere appunti e annotare le fonti utilizzate per poterle citare correttamente in seguito.
La tesi del testo
Una volta completata la fase di ricerca, è indispensabile stabilire una tesi. La tesi rappresenta l’affermazione principale del testo argomentativo e deve essere chiara, specifica e argomentabile. Deve esprimere la posizione dell’autore sull’argomento e guidare l’intero testo.
La struttura del testo argomentativo è un elemento fondamentale per una comunicazione chiara e coerente. Si consiglia di utilizzare una struttura tradizionale a paragrafi, che comprende introduzione, sviluppo e conclusione. Nell’introduzione, si presenta l’argomento, si cattura l’attenzione del lettore e si esprime la tesi. Lo sviluppo del testo espone i punti chiave dell’argomento e li sostiene con evidenze, argomenti logici e citazioni. Infine, la conclusione riassume i punti principali e ribadisce la tesi, lasciando un’impressione duratura.
Durante il corpo del testo, è importante fornire una serie di argomentazioni solide per sostenere la propria tesi. Ogni argomento deve essere presentato in un paragrafo separato e deve essere supportato da dati, fatti, statistiche, esempi e citazioni autorevoli. È fondamentale essere coerenti e logici nel collegamento delle argomentazioni.
Per rendere il testo ancora più solido, è consigliabile considerare le possibili controargomentazioni. Affrontare le obiezioni o le controargomentazioni che potrebbero essere sollevate contro la propria posizione rende il testo più convincente. È importante confrontare tali controargomentazioni con argomenti validi e offrire risposte convincenti per sostenere la propria tesi.
Lo stile di un testo argomentativo
Lo stile di scrittura di un testo argomentativo deve essere formale e chiaro. Bisogna evitare l’uso di linguaggio colloquiale o informale. È consigliabile essere chiari, concisi ed evitare divagazioni. Si deve utilizzare un linguaggio appropriato e coerente con il pubblico a cui ci si rivolge.
Le fallacie dell’argomentazione: errori comuni da evitare
Le chiamano “fallacie dell’argomentare” e rappresentano gli errori più comuni che si commettono nel tentativo di dimostrare una tesi. Queste argomentazioni si basano su presupposti deboli o errati, mettendo a rischio la loro confutabilità.
L’argomento ad hominem consiste nel trarre conclusioni sulla validità di una tesi basandosi sulle caratteristiche della persona che la sostiene. In sostanza, l’argomentazione dipende dal giudizio personale su qualcuno: ad esempio, si afferma che X è falso perché è stato detto da Giuda, un traditore. Come evitarlo? È necessario valutare l’argomento stesso anziché concentrarsi sulla persona, poiché anche i traditori possono dire la verità.
L’argomento ad ignorantiam si verifica quando si traggono conclusioni su una tesi, accettandola o respingendola, in assenza di dati certi e basandosi su convinzioni personali. Affermare che gli alieni non esistono perché non ci sono prove della loro esistenza non ha senso: la mancanza di dati su un argomento ci porta al massimo a non prendere posizione, ma non ci consente di sostenere quella che sembra più plausibile in base alle nostre inclinazioni personali.
L’argomento ad verecundiam si verifica quando si tenta di sostenere un argomento basandosi sull’autorità della persona che lo sostiene. Dire, ad esempio, che la meccanica quantistica non è completamente accettabile perché Einstein la riteneva incompleta significa: 1. ignorare gli sviluppi successivi del pensiero sulla meccanica quantistica dopo Einstein e 2. non considerare altre fonti autorevoli che potrebbero avere un parere contrario. Per evitarlo, è sufficiente tenere conto di più voci autorevoli.
La generalizzazione indebita si verifica quando si giunge a una conclusione basandosi su un numero troppo limitato di casi. Se non si hanno gli strumenti per valutare un elevato numero di casi, sarebbe opportuno evitare di trarre conclusioni basate su pochi esempi disponibili.
La fallacia di rilevanza o pertinenza si verifica quando le premesse sostengono una determinata conclusione, ma finiscono per sostenere l’opposto. Ad esempio, affermare che Mussolini era il direttore dell’Avanti!, quindi era un esponente di spicco del fascismo non ha senso: l’Avanti! era il quotidiano del partito socialista, e l’uso del “quindi” è totalmente fuori contesto.
L’inversione causale si verifica quando si scambia la causa con l’effetto di due eventi correlati: ad esempio, affermare che non si studia la matematica perché non si capisce potrebbe essere interpretato come non si capisce la matematica perché non si studia.
La non causa pro causa si verifica quando si conclude che qualcosa è causato da qualcos’altro che non è la sua causa effettiva: ad esempio, affermare che l’entrata degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale ha determinato la vittoria degli Alleati non ha senso. L’entrata in un conflitto non è l’unico elemento che determina l’esito di una guerra.
La petitio principii si verifica quando si assume come vero ciò che in realtà si desidera dimostrare: ad esempio, affermare che Ungaretti era un poeta molto famoso perché era celebre. Bisogna prestare attenzione all’uso del “perché”: la spiegazione che segue deve essere reale e non presupposta.
È fondamentale evitare queste fallacie dell’argomentazione per garantire una dimostrazione efficace e razionale delle nostre tesi. Prestando attenzione a queste trappole logiche, siamo in grado di costruire argomentazioni solide e basate su premesse valide, promuovendo così un dibattito e un ragionamento di qualità.
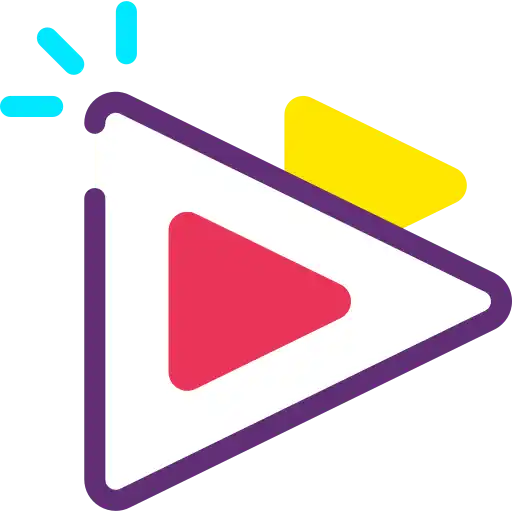 Programmazione Tv
Programmazione Tv









