La misurazione dell’intensità dei terremoti è un’importante procedura che utilizza due diverse scale per valutare gli effetti del sisma sul territorio e l’energia liberata durante l’evento. Le due scale più comunemente impiegate sono la scala Mercalli e la magnitudo Richter.

La scala Mercalli, originariamente proposta da Giuseppe Mercalli nel 1902 e successivamente modificata come scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg), si basa sugli effetti macroscopici del terremoto sulle cose e sul territorio, nonché sulle esperienze delle persone coinvolte. Questa scala descrive i diversi gradi di intensità del terremoto, dall’effetto strumentale impercettibile fino alla distruzione pressoché totale. I gradi vanno da I° a XII° e forniscono una rappresentazione dettagliata degli impatti del terremoto sulla vita quotidiana e sull’ambiente circostante.
D’altra parte, la magnitudo Richter (Ml) viene misurata in base all’energia sismica liberata durante il terremoto. Questa scala fu introdotta negli anni ’30 da Charles F. Richter e rappresenta un sistema logaritmico, in cui un aumento di un punto corrisponde a un aumento di dieci volte dell’energia liberata. Ad esempio, un terremoto di magnitudo 5 è dieci volte più potente di uno di magnitudo 4. La scala Richter viene utilizzata principalmente per i terremoti di piccola e media entità.
È importante sottolineare che la magnitudo Richter non è direttamente correlabile alla scala Mercalli, poiché gli effetti al suolo di un terremoto dipendono da diversi fattori, come la profondità del sisma e la struttura dei suoli e dei manufatti locali. Tuttavia, esiste un’equivalenza approssimativa tra le due scale per fornire un’indicazione generale. Inoltre, per i terremoti di grande intensità, viene spesso utilizzata la magnitudo del momento sismico (Mw), che tiene conto dell’area di rottura della faglia, dello slittamento lungo la faglia stessa e della resistenza massima alla rottura della roccia.
È fondamentale comprendere che la misurazione della magnitudo di un terremoto rappresenta solo l’energia liberata durante l’evento, mentre per valutare l’impatto effettivo e le conseguenze sulle persone e sulle infrastrutture, è necessario considerare anche la scala di intensità come la scala Mercalli. La scala Mercalli fornisce informazioni dettagliate sugli effetti sull’ambiente circostante e sulla vita delle persone coinvolte, tenendo conto dei fattori specifici di un’area colpita, come la densità di popolazione e la qualità delle infrastrutture locali.

La scala Mercalli
La scala Mercalli è uno strumento fondamentale nel valutare l’intensità di un terremoto basandosi sui danni che esso provoca alle persone, alle cose e alle strutture. Ciò che rende questa valutazione unica è che non richiede l’uso di strumenti di misurazione, ma si basa su una descrizione dei fenomeni osservati. Inoltre, può essere applicata anche per classificare i terremoti avvenuti in passato, di cui rimane una descrizione scritta. I valori di questa scala vanno da I a XII e vengono espressi con numeri romani.
La storia di questa scala risale alla sua versione originaria, chiamata scala Rossi-Forel, composta da 10 gradi. Tuttavia, è grazie al sismologo e vulcanologo italiano Giuseppe Mercalli che essa ha ricevuto il suo nome e ha raggiunto fama mondiale. Nel corso degli anni, la scala è stata rivista e aggiornata nel 1883 e nel 1902, quando Mercalli l’ha presentata alla comunità scientifica.
Nel 1902, lo scienziato italiano Adolfo Cancani ha ampliato la scala Mercalli da 10 a 12 gradi. Successivamente, il geofisico tedesco August Heinrich Sieberg ha completamente riscritto la scala, e da allora è diventata nota come scala Mercalli-Cancani-Sieberg, abbreviata come MCS o Scala Mercalli.
È importante sottolineare che due terremoti con la stessa magnitudo possono avere diverse intensità, a seconda della profondità dell’ipocentro o della presenza di zone densamente popolate. Ad esempio, un terremoto di grande magnitudo che si verifica in mezzo al deserto, dove non ci sono edifici, potrebbe avere una minore intensità (grado Mercalli inferiore) rispetto a un altro terremoto di magnitudo inferiore che colpisce un’area rurale densamente abitata senza costruzioni antisismiche. Pertanto, non ha molto senso confrontare i valori della scala Richter, che misura una grandezza fisica, con quelli della scala Mercalli, basata sugli effetti prodotti.
La scala Mercalli-Cancani-Sieberg si articola in 12 gradi di intensità, che vanno dall’impercettibile (grado I) alla distruzione totale (grado XII). Ogni grado corrisponde a diversi effetti sul territorio e sulla popolazione, come caduta di oggetti, danni alle abitazioni, lesioni negli edifici e, nei casi più gravi, distruzione completa e vittime umane. Questa scala offre una valutazione completa degli effetti di un terremoto, tenendo conto dell’impatto sulla vita delle persone e delle comunità coinvolte.
La scala Mercalli non è definita in relazione a grandezze fisiche misurabili oggettivamente, come ampiezza della scossa, velocità di picco o accelerazione. Ciò le conferisce il vantaggio di essere utilizzata anche in assenza di strumenti specifici e di poter essere applicata anche per descrivere.
La scala Richter (Ml)
La Scala Richter è un metodo di misurazione della magnitudo sismica, che rappresenta l’energia liberata da un terremoto al punto di rottura della crosta terrestre, ovvero all’ipocentro. Questo sistema di valutazione, ideato dal geofisico statunitense Charles Richter, permette di quantificare l’intensità dei terremoti in base a criteri scientifici precisi.
La storia della Scala Richter risale al 1935, quando Charles Richter, in collaborazione con Beno Gutenberg, entrambi del California Institute of Technology, sviluppò questo metodo di misurazione. Inizialmente, la scala era stata concepita per essere utilizzata solo in una specifica area della California e per i sismogrammi registrati da un particolare tipo di sismografo, chiamato sismografo a torsione di Wood-Anderson.
Nella definizione di Richter, la magnitudo di un terremoto è calcolata utilizzando il logaritmo in base dieci dello spostamento massimo registrato dal sismografo rispetto allo zero, espresso in micrometri. Questa misurazione è effettuata su un sismografo a torsione di Wood-Anderson calibrato in modo standard, supponendo che l’evento sismico si sia verificato a una distanza epicentrale di 100 km.
Richter scelse arbitrariamente una magnitudo zero per un terremoto che mostrasse uno spostamento massimo di un micrometro sul sismografo di Wood-Anderson, posto a 100 km di distanza dall’epicentro del terremoto. Questa scelta fu fatta per evitare numeri negativi, considerando le limitazioni degli strumenti dell’epoca. Tuttavia, la scala Richter non ha un limite inferiore o superiore concettuale, e i moderni sismografi più sensibili possono registrare terremoti con magnitudo negativa.
Uno dei principali problemi della scala Richter è che i suoi valori sono debolmente correlati alle caratteristiche fisiche che causano i terremoti. Inoltre, esiste un fenomeno di saturazione verso le magnitudini 8,3-8,5, che è dovuto alla legge di scala dello spettro dei terremoti. Questo fenomeno fa sì che i tradizionali metodi di misurazione della magnitudo producano lo stesso valore per eventi sismici chiaramente diversi. All’inizio del XXI secolo, la maggior parte dei sismologi ha considerato obsolete le tradizionali scale di magnitudo e le ha sostituite con una misura chiamata momento sismico, che è più direttamente correlata ai parametri fisici del terremoto. Nel 1979, il sismologo Hiroo Kanamori, anch’egli del California Institute of Technology, ha proposto la scala di magnitudo del momento (MW), che consente di esprimere il momento sismico in modo simile alle scale di magnitudo precedenti.
Come si determinano le scale di misura del terremoti
La misura della magnitudo di un terremoto è un indicatore della quantità di energia trasportata dalle onde sismiche e viene calcolata analizzando il sismogramma, ossia il grafico che registra l’ampiezza massima delle oscillazioni e la stima della distanza dell’epicentro rispetto alla stazione sismografica. Questo metodo di valutazione, sviluppato dal geofisico Charles Richter, si basa su misure scientifiche precise.
La definizione di Richter stabiliva che un terremoto di magnitudo 0, a una distanza di 100 km dalla stazione di riferimento, generasse un’ampiezza di traccia sul sismogramma di 1 micron. Successivamente, Richter assegnò le magnitudo 1, 2 e così via, ai terremoti che, alla stessa distanza, causavano un’ampiezza di oscillazione 10, 100 volte superiore rispetto al terremoto di magnitudo 0.
Il calcolo della magnitudo standard per le onde di volume si basa sulla formula:
mb = log10 (A / T) + Q (D, h)
dove A rappresenta l’ampiezza del movimento del suolo (misurata in micron), T è il periodo corrispondente (in secondi) e Q (D, h) è un fattore di correzione che dipende dalla distanza D (in gradi) tra l’epicentro e la stazione sismografica e dalla profondità focale h (in chilometri) del terremoto.
Per le onde superficiali, la formula standard è:
MS = log10 (A / T) + 1.66 log10 (D) + 3.30
Esistono variazioni di queste formule che considerano gli effetti specifici delle diverse regioni geografiche, in modo che la magnitudo calcolata sia coerente con la definizione originale di Richter. Sono consentiti valori di magnitudo negativi.
La scala mb solitamente utilizza ampiezze delle onde compressive P di 1 secondo, mentre la scala MS si basa sulle onde superficiali di Rayleigh con periodo T compreso tra 18 e 22 secondi.
Inizialmente, si pensava che tutte le dimensioni di terremoti irradiassero proporzioni fisse di energia a periodi diversi. Tuttavia, si è scoperto che i terremoti più grandi, con superfici di rottura maggiori, emettono sistematicamente più energia a lungo periodo. Di conseguenza, le magnitudo delle onde di volume sottostimavano la vera dimensione dei terremoti molto grandi, con una massima magnitudo di circa 6.5-6.8. Anche le magnitudo delle onde superficiali sottostimavano la dimensione dei terremoti più grandi, con valori massimi osservati intorno a 8.3-8.7. Alcuni ricercatori hanno suggerito l’utilizzo delle onde Love di 100 secondi per stimare la magnitudo dei terremoti di grandi dimensioni. Tuttavia, questo approccio non tiene conto del fatto che i danni alle strutture sono spesso causati da energia a periodi più corti (frequenze elevate). Pertanto, i sismologi moderni si affidano sempre di più a due parametri separati per descrivere gli effetti fisici di un terremoto: il momento sismico e l’energia irradiata.
La geometria della faglia e il momento sismico sono parametri che descrivono l’orientamento, la direzione del movimento e la dimensione di un terremoto. Questi parametri vengono determinati analizzando le forme d’onda dei sismogrammi generati dal terremoto. Il momento sismico è legato ai parametri fondamentali del processo di fagliazione ed è calcolato utilizzando la formula MO = μS<d>, dove μ rappresenta la resistenza al taglio della roccia fratturata, S è l’area della faglia e <d> è lo spostamento medio tra le parti contigue della faglia.
È stata introdotta una nuova scala di magnitudo chiamata magnitudo momento (Mw), che non raggiunge la saturazione, definita come:
Mw = 2/3 log10 (MO) – 10.7
I due terremoti con i momenti sismici più grandi mai registrati sono stati di 2,5 x 10^30 dyn·cm per il terremoto del Cile del 1960 (MS 8.5; Mw 9.6) e 7,5 x 10^29 dyn·cm per il terremoto dell’Alaska del 1964 (MS 8.3; Mw 9.2).
L’energia irradiata da un terremoto è una misura del potenziale dannoso per le strutture. Tradizionalmente, il calcolo di questa energia si basava sulla relazione empirica sviluppata da Beno Gutenberg e Charles Richter:
Log10E = 11.8 + 1.5 MS
dove E rappresenta l’energia espressa in erg. Tuttavia, questa formula presenta limitazioni poiché la magnitudo MS viene calcolata considerando un’ampiezza di banda tra circa 18 e 22 secondi. Oggi si sa che l’energia irradiata da un terremoto è concentrata su una banda diversa e a frequenze più elevate. Grazie all’utilizzo di moderni sismografi digitali con ampiezze di banda più ampie, i metodi di calcolo sono in grado di stimare in modo preciso l’energia sismica per tutti i grandi terremoti. È stata definita una magnitudo basata sull’energia irradiata, chiamata Me, che può essere calcolata utilizzando la formula:
Me = 2/3 log10E – 2.9
Ogni unità di aumento nella magnitudo corrisponde a un aumento di circa 32 volte dell’energia sismica. Nonostante Mw e Me siano entrambe magnitudo, descrivono proprietà fisiche diverse del terremoto. Mw, calcolata dai dati sismici a bassa frequenza, rappresenta una misura dell’area fratturata del terremoto, mentre Me, calcolata dai dati sismici ad alta frequenza, rappresenta il potenziale sismico dei danni. Pertanto, Mw e Me spesso non hanno lo stesso valore numerico.
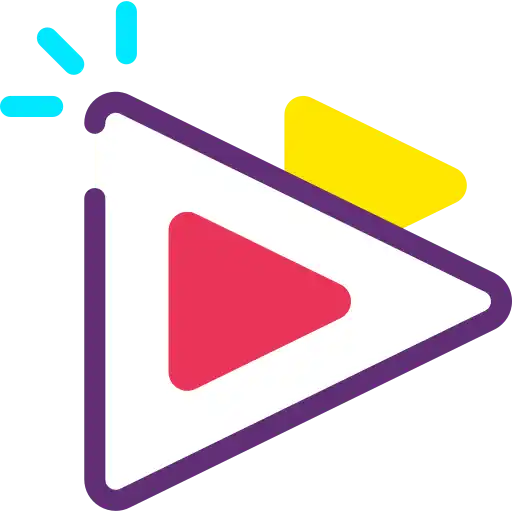 Programmazione Tv
Programmazione Tv









