Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.
La preghiera simbolo nata dal Concilio di Nicea
Il Credo, conosciuto anche come Simbolo della fede o professione di fede, rappresenta una sintesi dei principi fondamentali della fede cristiana. Le professioni di fede più rinomate e diffuse nella Chiesa cattolica sono il Simbolo Apostolico, risalente al II-III secolo e attribuito alla composizione degli Apostoli, e il Simbolo Niceno-Costantinopolitano, codificato dopo i Concili di Nicea (325) e di Costantinopoli (381). Comunemente noto come Credo, questo termine viene utilizzato poiché è la prima parola di tutte le professioni di fede.
Tuttavia, questi simboli non sono semplicemente istruzioni, ma vere e proprie professioni di fede. Il contenuto di queste professioni riguarda le verità della fede cristiana, tutte radicate nella parola “credo” (Giovanni Paolo II, Udienza generale del 13 marzo 1985).

Simbolismo del Credo cattolico
L’uso del termine “simbolo” per riferirsi a queste preghiere è meno diffuso. La parola “simbolo” deriva dal greco “sýmbolon”, che significa segno di riconoscimento. Era consuetudine, tra coloro che stipulavano un contratto o un accordo, scambiarsi un “simbolo”, spesso una moneta o un sigillo spezzati, conservandone un pezzo ciascuno. I due pezzi, unici nel loro combaciamento perfetto, garantivano ai contraenti (e spesso ai loro eredi) il riconoscimento reciproco in futuro. Ciascuno di questi due pezzi veniva chiamato “simbolo”. Da qui derivano i Simboli cristiani come professione di fede e come segno di riconoscimento nelle prime comunità cristiane: formule dottrinali brevi, semplici e precise che servivano a “riconoscersi” come comunità e a mantenere l’uniformità della fede.
Le origini bibliche del Credo sono evidenti sia nell’Antico Testamento, con il cosiddetto Credo deuteronomistico (Dt 26, 5-9), sia nel Nuovo Testamento, che riporta molte professioni di fede. La formula neotestamentaria più antica rintracciabile è quella utilizzata dall’eunuco della Regina di Etiopia (“Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio”, At 8, 37). Tuttavia, questa formula è stata omessa nella versione CEI 2008 del testo biblico in quanto si tratta di un’aggiunta antica, presente principalmente nel testo “occidentale”, ma assente nei manoscritti più autorevoli.
Sia il Simbolo Apostolico che il Simbolo di Nicea-Costantinopoli hanno un valore dogmatico e sono strettamente legati alle Sacre Scritture, mettendo in evidenza ciò che costituisce il cuore del messaggio biblico, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. Il Catechismo della Chiesa Cattolica stesso assume il Simbolo Apostolico, che rappresenta “il più antico catechismo romano” (CCC, n. 196), come base della propria esposizione, pur facendo riferimento costante al Simbolo di Nicea-Costantinopoli e ampliando la trattazione.
Simbolismo del Credo cattolico, io Credo?
Nel Simbolo, la parola “credo” appare quattro volte: tre volte seguita dalla preposizione “in” e una volta senza preposizione. Con “credo in” intendo esprimere un atteggiamento di fiducia, di incontro e di abbandono a Dio. “Credo in Dio” va oltre il semplice ritenere vero che Dio esista: anche i demoni lo sanno (Gc 2, 19). Tuttavia, essi non credono in Dio, cioè non affidano la propria esistenza alla Sua provvidenza, non lo amano, non gli obbediscono, non desiderano incontrarlo.
La quarta occorrenza della parola “credo” (“credo la Chiesa”) è molto diversa. Non dico “credo nella Chiesa” perché non affido la mia vita agli uomini che compongono la Chiesa. Dico invece “credo la Chiesa” per affermare che so che la Chiesa è opera di Dio e quindi sono grato a Lui e mi onoro di farne parte. Invece, affido la mia vita all’unico Dio, l’unico in grado di accogliere e sostenere la vita umana per l’eternità.
Credo in un solo Dio
Professiamo l’esistenza di un solo Dio perché Egli stesso si è rivelato al popolo d’Israele come l’Unico: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore” (Dt 6,4), e ancora “perché io sono Dio, non ce n’è altri” (Is 45,22). Cristo stesso ha confermato questo: “Il Signore nostro Dio è l’unico Signore” (Mc 12,29). Professare la Trinità, cioè credere che Gesù e lo Spirito Santo siano anch’essi Dio e Signore, non introduce divisione nel Dio Unico e non significa che esistono tre divinità o tre dèi. Il termine “Trinità” non compare esplicitamente nei Simboli o nella Sacra Scrittura: è il frutto di una riflessione su Dio, come ci è stato rivelato da Gesù, che si presenta come il Figlio unico del Padre e parla dello Spirito Santo come di un Altro. È la Tri-unità, la Trinità. Dio rimane Uno nella Sua essenza, anche se la Luce che i miei occhi percepiscono si manifesta attraverso tre colori diversi. La vera natura della Trinità rimane un mistero inspiegabile per l’uomo, che può solo avvicinarsi a essa con la ragione (CCC, nn. 200-202, 228, 232-237, 243-248, 257-260, 267).
L’unità di Dio impegna l’uomo a non sottomettersi alle leggi umane che portano all’idolatria: l’idolo del denaro (la legge del profitto, dell’egoismo, dello sfruttamento), l’idolo del piacere (la legge del consumismo, della soddisfazione degli interessi personali, del falso “progresso sessuale”), l’idolo della materia.
Il mistero della Risurrezione
La Risurrezione di Gesù, secondo le Scritture, non deve essere interpretata come una semplice resurrezione alla vita terrena come nel caso di Lazzaro, la figlia di Giairo o il figlio della vedova di Nain. La Risurrezione di Gesù è un evento unico, in cui Egli ha superato la morte in modo definitivo e ha ottenuto un corpo glorioso. Questo è conforme a quanto profetizzato dalle Scritture stesse, che avevano già annunciato che Dio avrebbe riscattato la vita e strappato l’uomo dagli inferi.
Il Mistero della Risurrezione si completa con l’Ascensione di Gesù, in cui Egli sale al cielo e si siede alla destra del Padre. Questo simboleggia il suo regno eterno come Figlio di Dio e il suo costante intercedere per noi presso il Padre. Gesù ha ripreso la gloria che aveva presso il Padre prima della sua incarnazione e ha preparato un posto per noi, inviandoci lo Spirito Santo come dono e speranza.
La venuta gloriosa di Cristo, chiamata Parusia, segnerà il trionfo definitivo di Dio e l’ultimo Giudizio. In quel momento, Cristo giudicherà il mondo con il potere che gli è stato dato come Redentore e Salvatore degli uomini. Saranno rivelati i segreti dei cuori e la condotta di ciascuno verso Dio e il prossimo. Ogni persona sarà ricompensata o condannata in base alle proprie opere. I cristiani vivono in attesa di questo momento e nella celebrazione eucaristica rinnovano la gioia nell’attesa della venuta di Cristo.
Credere nello Spirito Santo significa affidarsi alla sua guida e rinunciare agli spiriti del mondo che ci tengono legati alla schiavitù della materia e dell’egoismo. Lo Spirito Santo è la terza Persona della Trinità, distinta dal Padre e dal Figlio, e è anche chiamato Spirito Paraclito e Spirito di Verità. Egli è il Signore, cioè Dio stesso, e dà la vita umana e divina. Attraverso di Lui, possiamo accogliere Gesù come unica via di salvezza.

Lo Spirito Santo procede sia dal Padre che dal Figlio e viene adorato e glorificato insieme a Loro. Ha parlato per mezzo dei profeti, che sono stati ispirati da Lui per annunciare la volontà di Dio. Nel Nuovo Testamento, lo Spirito Santo compie le profezie dell’Antico Testamento, rivelando il mistero di Cristo. Egli è inviato dal Padre e dal Figlio per insegnarci tutte le cose e ricordarci ciò che Gesù ha detto. Tutto il testo sacro parla di Cristo, il quale esisteva anche prima di Abramo.
La Chiesa: Un’unica Famiglia, Santa, Universale e Apostolica
Nel Credo, si sottolinea un importante cambiamento: passiamo dal credere in qualcosa a credere qualcosa. In questo caso, la Chiesa diventa oggetto della nostra fede. Dio ci vuole uniti come una famiglia, come dei fratelli, affinché tutti possano essere una cosa sola (Gv 17, 21.22). Questa famiglia è chiamata Chiesa, il popolo che Dio convoca e raduna da ogni parte del mondo, per formare l’assemblea di coloro che, per la fede e il Battesimo, diventano figli di Dio, membri di Cristo e templi dello Spirito Santo. La Chiesa non può essere che una, perché la sua origine e il suo modello risiedono nell’unità di un solo Dio nella Trinità delle Persone. Essa ha come fondatore e capo Cristo, che ristabilisce l’unità di tutti i popoli in un solo corpo, mentre lo Spirito Santo unisce tutti i fedeli nella comunione con Cristo. La Chiesa possiede una sola fede, una sola vita sacramentale, una sola successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità.
L’unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, guidata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. È solo attraverso di essa che si può ottenere la pienezza dei mezzi di salvezza. Le divisioni che si sono create nel corso dei secoli a causa di peccati, incomprensioni e interferenze politiche sembrano aver generato diverse “chiese”, ma in realtà queste strappano e lacerano l’unica Chiesa, rappresentata dalla tunica di Cristo, senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo (Gv 19, 23). Oggi, di fronte alle pericolose deviazioni di molte “chiese” che si allontanano sempre più da Cristo, l’unica Chiesa sta lentamente ma progressivamente riacquistando la sua unità, secondo la volontà di Dio e per la sua gloria. L’unica Chiesa è anche afflitta dalla formazione di “sette” partitiche attorno a diversi predicatori, anche all’interno della stessa Chiesa cattolica, come avveniva ai tempi di San Paolo: “Ciascuno di voi dice: ‘Io sono di Paolo’, ‘Io sono invece di Apollo’, ‘Io sono invece di Cefa’, ‘E io sono di Cristo’. Forse Cristo è diviso?” (1Cor 1, 12-13).
Nelle Sacre Scritture, si fanno riferimenti alla Chiesa attraverso immagini. L’Antico Testamento privilegia quelle legate al popolo di Dio, mentre il Nuovo Testamento utilizza immagini collegate a Cristo come Capo di questo popolo, che è il suo Corpo. Vengono usate anche immagini legate alla vita pastorale (gregge), agricola (vigna), abitativa (pietra) e familiare (sposa) (CCC, 751-757, 777, 804, 816, 870).
Tutti i membri della Chiesa sono peccatori, compreso il Pontefice. Tuttavia, la Chiesa è santa grazie alla santità di Dio. Infatti, Dio Santissimo è il suo autore e Cristo si è sacrificato per santificarla e renderla santificante. Lo Spirito Santo la vivifica con la carità. La santità è anche la vocazione di ogni membro della Chiesa e il fine di ogni sua attività. La Chiesa annovera tra i suoi membri la Vergine Maria e innumerevoli Santi, che fungono da modelli e intercessori. La santità della Chiesa è la fonte della santificazione dei suoi figli. Nonostante le cadute umane dei suoi membri, Cristo mantiene viva la sua presenza nel suo popolo e, perdonandolo, dimostra ancora di più la sua santità.

Unità della Chiesa
L’unità e l’universalità della Chiesa generano un altro titolo che noi professiamo: cattolica (dal greco: καθολικός, katholikòs, universale). Cristo è il capo del corpo che è la Chiesa e, in quanto Dio, è presente ovunque: “Dove è Cristo Gesù, là è la Chiesa cattolica” (sant’Ignazio di Antiochia). La Chiesa è inviata in missione a tutti i popoli e in ogni epoca, indipendentemente dalla loro cultura. La Chiesa si trova ovunque gli uomini si radunano nel nome di Cristo, secondo la sua promessa: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20). Pertanto, è un errore identificare il termine “cattolico” con i “confini” della Chiesa di Roma, in contrapposizione ad altre denominazioni cristiane. Nel Credo, il termine cattolico non mette l’accento sulle divisioni create nella storia a causa dei peccati degli uomini, ma sulla volontà di Dio di avere una sola famiglia su tutta la terra (cfr. Gv 17,20-26). “Le Chiese particolari sono pienamente cattoliche per la comunione con una di esse: la Chiesa di Roma, ‘che presiede alla carità'” (CCC, 834). “Tuttavia, dobbiamo stare attenti a non concepire la Chiesa universale come la somma o, per così dire, la federazione di Chiese particolari” (Paolo VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 62).
La Chiesa è apostolica perché è fondata sulla testimonianza di fede dei dodici Apostoli. Essa possiede e trasmette interamente e unicamente la fede degli Apostoli e ha ricevuto da loro l’autorità divina. Siamo costruiti sulla fondazione degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù (Ef 2,20) (CCC, 823-831, 857, 867-869).
Un’unica professione di fede
In un’unica professione di fede, si esprime la volontà di aderire esclusivamente al sacramento del Battesimo per ottenere il perdono dei peccati. Nonostante l’abbia ricevuto gratuitamente da neonato, senza una partecipazione libera e consapevole, ora che se ne comprende il valore, si desidera vivere il Battesimo in modo completo e consapevole. Questo sacramento rappresenta l’atto esteriore che manifesta il cambiamento interiore del credente e costituisce il suo ingresso come membro nel popolo di Dio. È Gesù stesso a insegnarci il valore del Battesimo, affermando: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio” (Gv 3,5).
Attraverso la professione di un unico Battesimo, il credente manifesta la volontà di unirsi solo al Dio Trinità attraverso il Battesimo nella sua unica Chiesa. L’esigenza di sottolineare l’esistenza di un solo Battesimo non è affatto superata: sebbene fossero presenti diverse usanze di altri battesimi in nome di false divinità nei primi secoli, oggi si trovano molteplici falsi battesimi e varie iniziazioni che presumono di plasmare la nostra vita, spesso celate dietro un’apparenza positiva, con connotazioni sataniche, religiose, politiche, sociali o culturali. Ripetere il Battesimo non ha senso, sarebbe un atto di sfiducia verso Dio, il quale rimane fedele e non può rinnegare se stesso (2Tm 2,13).
Poiché nasciamo con il peccato originale, anche i neonati hanno bisogno di essere liberati dal potere del Maligno e di essere trasferiti nel regno della libertà come figli di Dio. Per ottenere il perdono dei peccati, non sono più necessari sacrifici di animali o, ancor peggio, di persone come nei riti pagani, né riti magici come quelli praticati dagli atei moderni. Il perdono è possibile e Dio si compiace di donarlo, pertanto non ci si arrende né ci si dispera: non si accetta di rimanere nel peccato né si si agita per il fatto di essere peccatori, ma si ritorna sempre al Signore pentendosi, conscio della sua ricchezza di misericordia. Ogni cristiano vive del perdono.
Nell’Antica Alleanza si trovano varie prefigurazioni del Battesimo, come l’acqua, che rappresenta la fonte di vita e di morte; l’arca di Noè, che salva attraverso l’acqua; il passaggio del Mar Rosso, che libera Israele dalla schiavitù in Egitto; la traversata del Giordano, che introduce Israele nella terra promessa, simboleggiante la vita eterna. Nel Nuovo Testamento, Gesù, all’inizio della sua vita pubblica, si fa battezzare da Giovanni Battista nel fiume Giordano; sulla Croce, dal suo fianco trafitto, sgorgano sangue e acqua, simboli del Battesimo e dell’Eucaristia; dopo la sua Risurrezione, affida agli Apostoli la missione di “andare e fare discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19).
Il Simbolo degli Apostoli presenta altre espressioni che meritano di essere analizzate almeno brevemente per la loro grande importanza. Con l’espressione “comunione dei santi” si intende la partecipazione comune di tutti i membri della Chiesa alle cose sante, come la fede, i sacramenti, in particolare l’Eucaristia, i carismi e gli altri doni spirituali. Tale espressione si riferisce anche alla comunione tra le persone sante, cioè coloro che, per grazia, sono uniti a Cristo morto e risorto. Alla base di questa comunione c’è la carità, che spinge il fedele a mettere tutto in comune (At 4,32).
Il primo e principale sacramento per ottenere il perdono dei peccati è il Battesimo. Per i peccati commessi dopo il Battesimo, Cristo ha istituito il sacramento della Riconciliazione (o Penitenza), mediante il quale il battezzato può riconciliarsi con Dio. La Chiesa ha il compito e il potere di perdonare i peccati, poiché Cristo stesso gliel’ha conferito: “Detto questo, soffiò e disse loro: ‘Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati'” (Gv 20,22-23). Per approfondire il sacramento della Confessione, i suoi fondamenti biblici, una breve guida pratica alla Confessione e uno schema utile per l’esame di coscienza, si può leggere qui.
Il termine “carne” indica l’uomo nella sua condizione di debolezza e mortalità, eppure la carne è il fulcro della salvezza (come afferma Tertulliano): infatti, crediamo in Dio come creatore della carne; crediamo nel Verbo che si è fatto carne per redimere la carne; crediamo nella risurrezione della carne, che rappresenta il compimento della creazione e della redenzione della carne. Con la morte, che separa l’anima dal corpo, il corpo cade nella corruzione, mentre l’anima, che è immortale, attende il giudizio di Dio e la ricongiunzione con il corpo, che avverrà alla seconda venuta di Cristo, quando risorgerà trasformato. Ciò significa che lo stato finale dell’uomo non sarà soltanto l’anima separata dal corpo, ma, così come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, Egli risusciterà tutti nell’ultimo giorno, con un corpo incorruttibile: coloro che hanno fatto il bene risorgeranno per la vita eterna, mentre coloro che hanno compiuto il male risorgeranno per la condanna (Gv 5,29).
La vita eterna inizia immediatamente dopo la morte e non ha fine. Ogni individuo sarà sottoposto a un giudizio particolare da parte di Cristo, il giudice dei vivi e dei morti, e la vita eterna sarà confermata nel Giudizio finale (CCC, nn. 946-962, 976, 980-987, 990, 998, 1002-1003, 1015, 1020, 1051).
Attendo con speranza la risurrezione dei morti
L’ultima frase del Simbolo niceno-costantinopolitano rivela le profonde speranze e aspettative che un cristiano nutre per il futuro che va oltre la morte. Non ci attende la scomparsa nell’oblio di una carne morta, né la perdita dell’identità personale in un vago dissolversi in Dio, ma piuttosto una risurrezione che ci aprirà alla vita autentica e alla gioia del tesoro eterno. Questo ci fa considerare la Terra come un luogo di pellegrinaggio e di attesa della nostra vera patria. Grazie a questa attesa, vivo con gioia il presente, senza mai cedere all’inerzia: “Esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre raggiungete la meta della vostra fede” (1Pt 1,8-9).
Questa attesa dovrebbe anche spingere l’uomo a vivere responsabilmente i suoi giorni, poiché tutti dovranno rendere conto a Colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti (1Pt 4,5). La vita eterna è quindi un dono di Dio, un dono che ci consola e ci conferisce una grande responsabilità. Questo dono mi spinge a vivere con serietà e serenità, per sviluppare una vita umana autentica, in netto contrasto con la vita di coloro che rifiutano questo dono. Quest’ultima è caratterizzata da un profondo vuoto di valori e una disperazione pervasiva, che può essere percepita e vissuta più o meno consapevolmente, ma non per questo meno presente.
Dopo il giudizio finale, persino l’universo stesso, liberato dalla corruzione, parteciperà alla gloria di Cristo mediante la creazione di nuovi cieli e una nuova terra, dove regna la giustizia (2Pt 3,13). In questo modo, il Regno di Dio raggiungerà la sua pienezza, ossia l’ultima realizzazione del disegno salvifico di Dio, e Egli sarà “tutto in tutti” (1Cor 15,28).
Amen
La parola ebraica Amen, che conclude anche l’ultimo libro della Sacra Scrittura, alcune preghiere del Nuovo Testamento e quelle liturgiche della Chiesa, rappresenta il nostro totale e fiducioso “sì” a ciò che abbiamo professato nella nostra fede, confidando pienamente in Colui che è l’Amen, il Testimone degno di fede e veritiero, il Principio della creazione di Dio (Ap 3,14): il Signore Cristo (CCC, nn. 1042-1050, 1060-1065).
Altre domande frequenti
Sempre su questo argomento
- Preghiera della Sera
- Augurare Buonanotte con una Preghiera
- Litanie Lauretane
- Preghiere della Sera
- Preghiere della Sera prima di dormire
- Rosario al Sacro Cuore di Gesù
- Frasi belle, quali sono e come scegliere le migliori belle frasi
- Che differenza c’è tra il tutore e il curatore?
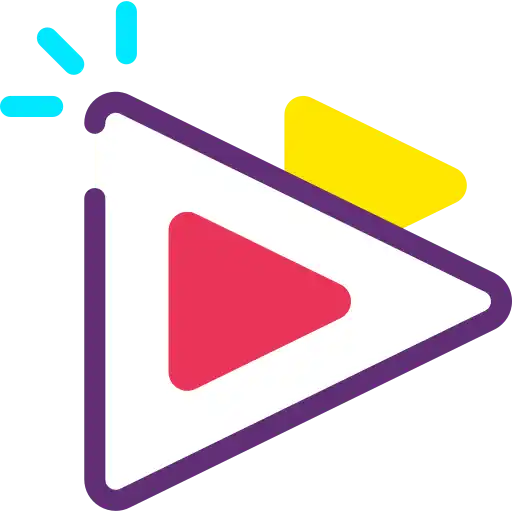 Programmazione Tv
Programmazione Tv









